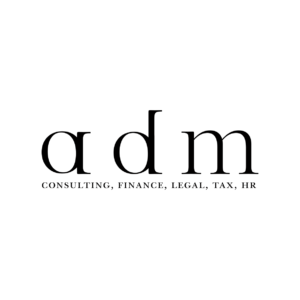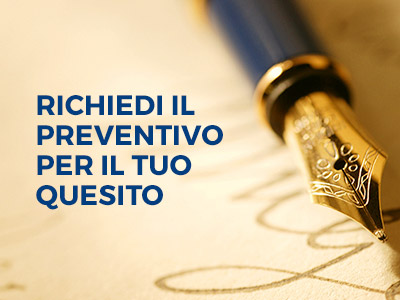Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede che il mutuo erogato da un privato che non agisce nell’esercizio della sua attività professionale o di impresa sia soggetto (in qualunque forma sia redatto, e cioè indipendentemente dal fatto che sia usata la forma della scrittura privata non autenticata, della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico) a registrazione in “termine fisso”, entro 20 giorni dalla data dell’atto, con l’aliquota del 3% (Tariffa, parte I, art. 9 del D.P.R. 131/86: “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”).
Quanto alla determinazione della base imponibile cui applicare detta aliquota, vale il disposto dell’art. 43, comma 1, lett. h), TUR, per il quale essa è data “dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”: pertanto, in caso di mutuo non fruttifero, dalla somma mutuata e, in caso di mutuo fruttifero, dalla somma mutuata maggiorata degli interessi dovuti dal mutuatario.
Inoltre, l’atto sconta anche l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni quattro facciate.
Nel caso in cui il contratto sia formato per corrispondenza, la registrazione del prestito va effettuata solo “in caso d’uso” (Tariffa, Parte II, art. 1, lett. a) del D.P.R. 131/86) con la medesima tassazione prevista per il caso in cui contratto fosse soggetto a registrazione in “termine fisso”.
Il “caso d’uso” ricorre quando avviene il deposito di un atto:
– presso una cancelleria giudiziaria, nell’esplicazione di attività amministrative;
– presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un obbligo nei confronti delle suddette amministrazioni, o sia obbligatorio per legge o regolamento.
Per quanto riguarda il concetto di corrispondenza, la legge non specifica che si debba necessariamente trattare di spedizione postale (anche se l’utilizzo del servizio postale rappresenta senz’altro la best practice in questa materia). Inoltre, il concetto di corrispondenza presuppone un duplice invio documentale: dal mittente al destinatario e da questi al mittente.