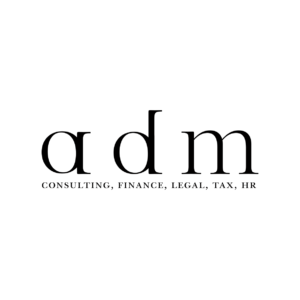La recente pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 3311 dell’08.02.2017) offre lo spunto per accennare brevemente alle problematiche ed incertezze che, da tempo, dominano lo scenario del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al problema della riservatezza che, soprattutto negli ultimi anni, per quanto attiene alla raccolta e gestione di informazioni mediante strumenti informatici, è divenuto di grande attualità.
La Corte di Cassazione, pur ponendosi nel solco dei principi affermati dalla giurisprudenza e dottrina prevalenti in materia, è consapevole dei limiti persistenti del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale che, già in diverse occasioni, ha manifestato l’incapacità di rimanere aggiornato alla continua evoluzione delle nuove figure di danno.
Il c.d. “danno da spamming”, inteso come danno derivante da comunicazione elettronica a carattere commerciale non sollecitata, rappresenta certamente una di tale moderne tipologie di danno.
Il diritto alla riservatezza rappresenta “l’esigenza di ogni individuo ad escludere dall’altrui conoscenza quanto ha riferimento alla propria persona” (De Cupis).
Il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si rinviene nell’art. 2 Cost. e nelle sue specificazioni (artt. 13, 14, 15), nonché nell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della vita privata e familiare, oltre che del domicilio e della corrispondenza.
Nel caso in esame alla Suprema Corte, un soggetto conveniva in giudizio una società di professionisti chiedendo ne fosse accertata la responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno, per il fatto di avergli inviato al proprio indirizzo e-mail, senza il suo preventivo consenso, alcuni messaggi di posta elettronica.
La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, esponendo, tra i vari motivi, che, da un lato, i dati relativi alla casella di posta elettronica del ricorrente erano stati richiesti all’Ordine degli Avvocati (ricorrendo pertanto l’esimente di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1, lett. c) – che autorizza il trattamento dei dati provenienti da pubblici elenchi o registri senza il consenso dell’interessato) e, dall’altro, che non vi era alcuna prova dell’esistenza di danni collegabili alla propria condotta.
Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea poiché – a prescindere dai profili relativi alla legittimità del trattamento dei dati personali – non era stata prodotta in giudizio alcuna prova dell’esistenza e dell’entità del danno, avendo la società convenuta inviato solo poche e-mail (nello specifico caso, dieci) in un arco temporale di tre anni.
L’attore di primo grado ricorreva così per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte provvedeva a dichiarare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso “avendo il giudice di merito fatto applicazione del condivisibile principio secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva; il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. n. 16133/2014) che, nella specie, lo ha espresso con motivazione adeguata e incensurata”.
La vicenda giudiziaria in commento ha fornito ai giudici di legittimità l’ulteriore occasione per pronunciarsi sulla complessa tematica del danno non patrimoniale con particolare riguardo alle condizioni che ne rendono ammissibile il risarcimento.
Il danno non patrimoniale – categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in ulteriori sottocategorie, se non per fini meramente descrittivi – anche quando sia determinato da lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza che va provato nel suo preciso ammontare: assunto che ha trovato definitiva consacrazione nelle ormai note sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. Civ., S.U., 11 novembre 2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975).
In particolare, quanto al danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la disposizione normativa richiamata disciplina il tema della responsabilità civile per i danni procurati dal trattamento di dati personali: l’art. 15 sancisce, al primo comma, che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile” e, al secondo comma, che “il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11”.
Ai sensi dell’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il danno da lesione del diritto alla riservatezza, quale diritto ad escludere altri dalla conoscenza di vicende strettamente personali o familiari, non si sottrae dunque alla verifica della “gravità della lesione” – relativa al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall’art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della libertà umana e della sua dignità – e della “serietà del danno” – quale perdita di natura personale concretamente patita dall’interessato – che, in linea generale, si richiede in applicazione dell’art. 2059 c.c., nell’ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione.
L’art. 2059 c.c., principio informatore del diritto, riletto in un’interpretazione costituzionalmente orientata, consente di individuare nella norma la disciplina dei limiti e delle condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell’esistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile richiesti ai sensi dell’art. 2043 c.c. (norma cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale): il fatto materiale (che comprende la condotta illecita, l’evento dannoso, il nesso di causalità), l’antigiuridicità (o ingiustizia del danno), la colpevolezza del soggetto che ha compiuto l’atto (atto che deve essere frutto di un “comportamento disapprovato dall’ordinamento”).
Risarcibile sarà, pertanto, solo quel danno da considerarsi serio a fronte di una lesione grave: lesione che deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il torto tanto serio da essere meritevole di tutela in un ordinamento che richiede un limite minimo di tollerabilità e che impone al soggetto danneggiato di sopportare un danno che sia futile senza poterne pretendere il risarcimento.
Un diritto fondamentale quello alla protezione dei dati personali – espressione di una concezione dinamica della riservatezza intesa quale potere di esercitare un controllo sulle proprie informazioni – che vive non isolatamente, ma che deve confrontarsi e rapportarsi necessariamente e costantemente con gli altri diritti fondamentali e inviolabili della persona umana garantiti dall’ordinamento.
In un contesto di necessario bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, di cui al dovere costituzionale di solidarietà sociale, il diritto alla protezione dei dati personali di un soggetto dovrà quindi convivere con il corrispondente diritto ed interesse di altri soggetti a venire a conoscenza di quegli stessi dati.
Per una consulenza legale contattateci all’indirizzo info@admassociati.it